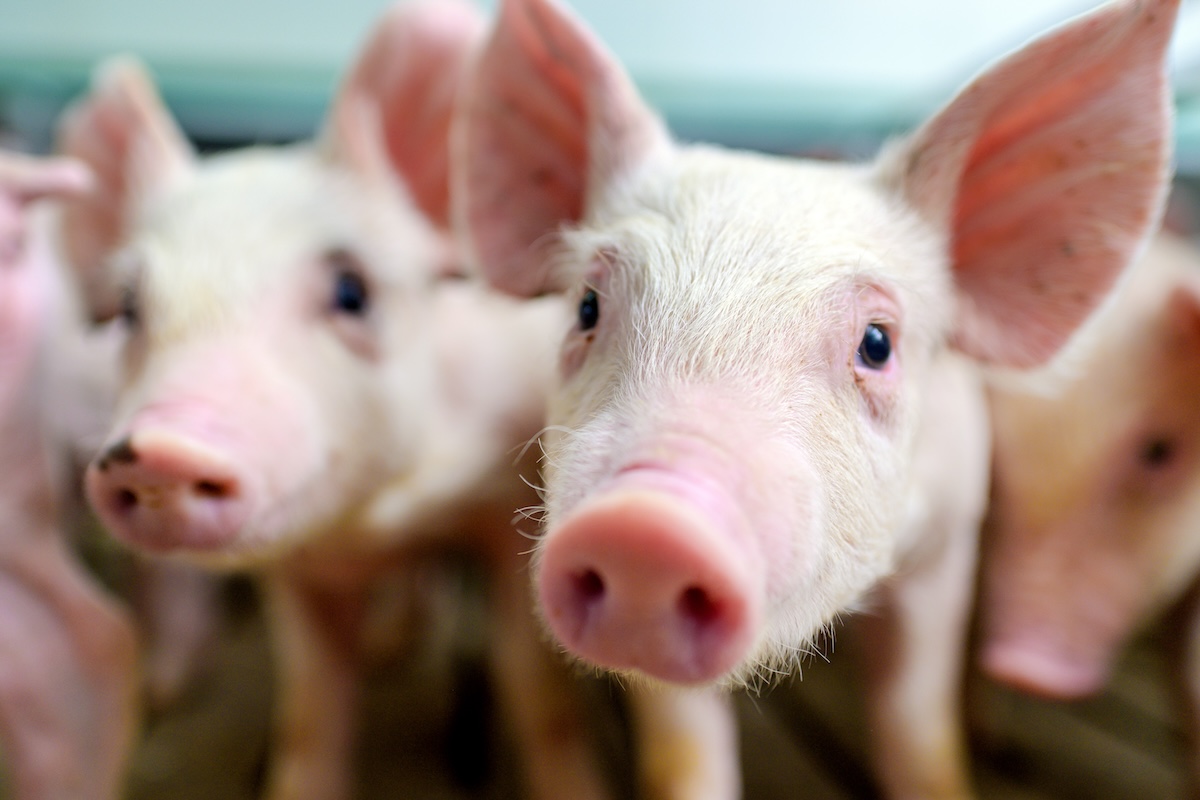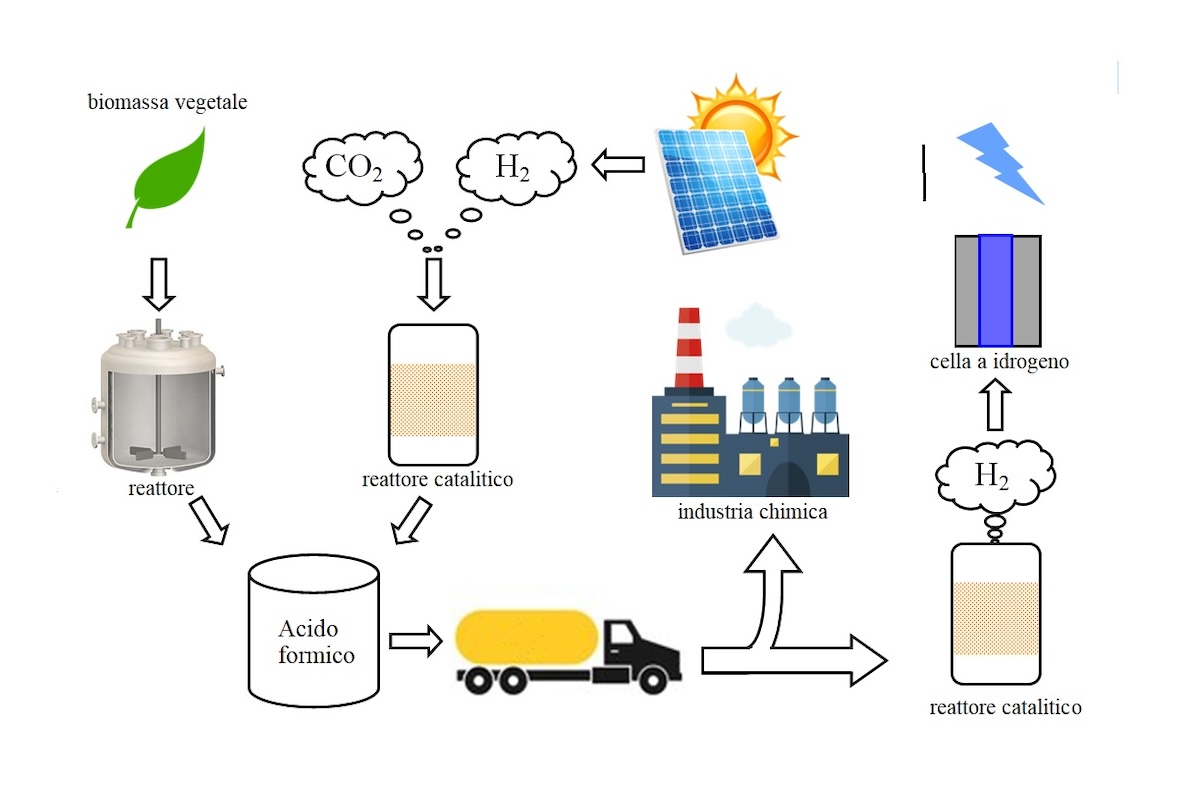Personalmente, ho deciso per un giorno di non addentrarmi nei temi caldi al cui centro è posta l'agricoltura, come effetto serra, fame nel mondo, erosione, residui oppure Ogm. Né di analizzare in dettaglio le conseguenze per il comparto agricolo, positive e negative, che deriveranno dalla recente Direttiva Ce 128/2009, meglio conosciuta come "Usi sostenibili".
Ho preferito invece interrogarmi sulle dinamiche sociali, economiche e culturali che hanno portato a questa situazione. E le risposte ho finito col trovarle lontane dai campi coltivati.
Prima della seconda guerra mondiale di una direttiva sugli usi sostenibili non se ne sentiva affatto bisogno. Eppure, oltre metà della popolazione italiana era agricola e viveva dispersa in una miriade di piccoli e medi insediamenti che avevano nella lavorazione della terra il proprio fulcro economico e sociale.
Della metà rimanente, la maggior parte insisteva comunque in quelle stesse aree a forte indirizzo rurale e rappresentavano un vero e proprio "indotto": fabbri ferrai, carrai, falegnami, negozi, officine, mulini e magazzini. E perché no, anche osterie e mercatini di piazza dove oltre a far la spesa si socializzava pure, soppesando la qualità di frutta e verdura rigorosamente locale e di stagione.
Le famiglie erano all'epoca molto numerose, eppure non sapevano cosa volesse dire avere un figlio disoccupato. Già da bambini, infatti, gli Italiani dell'era rurale venivano impiegati nei campi anziché andare a scuola. Ben lungi quindi dal sapere cosa fosse un "master in design", schiacciavano coi sassi le dorifore nei campi di patate, oppure aiutavano i più grandi nei lavori in fattoria.
Accudire gli animali di bassa corte era affare da bambine (la discriminazione sessuale imperava già allora), le quali inconsapevolmente surclassavano il moderno approccio del "km Zero" ogni qual volta portavano in casa dall'aia un ovetto fresco con cui fare le tagliatelle della domenica.
Viti maritate e trasemina di leguminose erano pratiche comuni, come pure il sovescio, le rotazioni e la scerbatura manuale delle infestanti. Tranne che agli occhi concupiscenti del fattore, del resto, le mondine come diserbanti erano delle "Non classificate". "Utilizzabili" cioè anche senza "patentino".
L'agricoltura era quindi ben più che biologica o biodinamica: sconfinava addirittura nel rupestre. Emetteva meno CO2 di quanta ne prelevasse dall'atmosfera, difendeva i livelli di sostanza organica del suolo riciclando fino all'ultima deiezione animale e non. Con gli scarti di cucina si allevavano i maiali e i gusci delle uova venivano restituiti alle galline perché si ricaricassero di calcio.
Anche quello della raccolta differenziata, quindi, era un problema inesistente. Magari un po' di più lo era quello della Salmonella, ma se si sta a guardare tutto non si finisce mai un discorso.
Per scaldarsi non si usavano combustibili fossili, bensì residui di potatura o legna accuratamente selezionata nel bosco, mantenuto saggiamente pulito ed efficiente dal punto di vista idrogeologico.
Un quadro idilliaco, quindi. Una rappresentazione molto vicina a quelle spesso auspicate da una parte dell'intellettualità che disquisisce di agricoltura nei salotti buoni.
Cos'è che allora è andato storto? Forse, più che interrogarci su cosa facesse la componente rurale italiana, ci si dovrebbe interrogare sulle dinamiche di popolazione dell'altra parte: i cittadini.
Facendo un balzo in avanti di 70 anni, ci si ritrova all'improvviso in un incubo: il 97% delle persone non conosce più la differenza tra una vanga e un badile, pensa che le mele vengano raccolte 12 mesi all'anno e che il latte sia una bevanda industriale in fondo simile a una bibita, solo senza bollicine.
Di più: vivono in centri urbani congestionati di traffico, polveri sottili e nevrosi. Centri che da soli fanno la popolazione di intere Regioni agricole del famoso "Ventennio".
Comprano tutto nei supermercati dei grandi centri commerciali e non saprebbero riconoscere un albicocco da un susino. E mangiano. Cielo quanto mangiano! E così, rispetto ai loro bisnonni agricoltori sono ingrassati, hanno il colesterolo, soffrono d'ipertensione. Anche perché vivono e lavorano stando per lo più seduti: scrivanie, divani e poltrone.
L'agricoltura è per loro ciò che gli viene propinato dalla tv: spaccati di enogastronomia d'elite, oppure attori da reclame travestiti da vecchi contadini dal cappello di paglia e gibunetto di velluto che guidano calessi colmi di formaggi.
Praticamente, un "Truman Show" che diventa realtà.
Poi qualcuno li aizza. Dice loro che quei quattro gatti di agricoltori rimasti a lavorar la terra, mortacci loro, sono pure impazziti e hanno abbandonato le buone pratiche di un tempo che fu.
Oggi, pensate un po', invece di distribuire ancora a mano il letame e strappare le malerbe, quei lazzaroni inquinano: usano i pesticidi, i fertilizzanti chimici, allevano centinaia di vacche o maiali in ambienti ristretti, alimentandoli con mangimi spesso Ogm invece che con le più sane bucce di anguria.
Come hobby poi, quasi a far dispetto ai cittadini bisognosi di relax agreste domenicale, avrebbero perfino scelto quello di distruggere la biodiversità. Del resto in campagna alla sera ci si annoia molto e un qualche passatempo va pure cercato.
Ed ecco che "il popolo urbano repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa" (A. Manzoni: terzo coro di "Adelchi" - nda). E quindi protesta, tanto indignato quanto allarmato. Lui, il Cittadino, quello che non distingue un campo d'orzo da uno di frumento, punta i piedi e vuole tutto d'un tratto cibi a residuo zero, a chilometro zero, prodotti senza uso di pesticidi e fertilizzanti e, perché no, anche nella tutela del Fischione maculato della Val Frugazza.
Però, finita la gazzarra delle proteste, se trova una pesca o un acino d'uva con una beccatina di tripide, lascia lì tutto nei banconi. Medesimo destino patiscono le zucchine o i peperoni se non rispondono a ben precisi parametri di colore, forma e dimensioni. Un bollo di ticchiolatura su una mela? Un afide rimasto intrappolato nel lattughino? Giammai! Che se lo mangi quel cialtrone di agricoltore che l'ha prodotto.
Lui, il Cittadino, mica compra le confezioni belle e pronte di quarta gamma per trovarci poi dentro tracce di Natura. Perché la Natura, per il Cittadino, è qualcosa da godersi "on-demand" e non un'entità superiore che possa pensare di farsi trovare dove e quando pare a Lei.
Lui, quelle confezioni "apri e mangia" le compra per fare in fretta a pranzare per scappare subito a occuparsi di qualcos'altro. Mica ha più il tempo di lavarsela a mano (lui), l'insalata intera.
E quindi la grande distribuzione organizzata raccoglie (e amplifica) tutte queste voci e le riversa cinicamente sugli agricoltori, lasciati sempre più soli, sempre meno numerosi, sempre meno pagati, a dover strizzare sempre più terra e animali per sfamare questa miriade di cittadini che vogliono la moglie ubriaca (cibo abbondante e perfetto) e la botte piena (no ai residui, no ai concimi, si ai Fischioni maculati della Val Frugazza).
Cittadini che per di più gettano poi nella spazzatura tonnellate di cibo all'anno, infantilmente inconsapevoli della fatica umana e dei costi ambientali mondiali che la loro produzione ha comportato.
Ecco, tutto questo si che credo necessiti urgentemente la stesura di una nuova Direttiva Ce: la "Cervelli sostenibili". Al punto uno della Direttiva metterei per tutti i "cittadini" l'obbligo alla visione del film di Ermanno Olmi "L'albero degli zoccoli", del 1978. Forse capirebbero perché i loro bisnonni hanno abbandonato i massacranti lavori nelle campagne per finire nelle grinfie delle città.
E forse capirebbero anche che se la smettessero di pretendere la luna e si accollassero la propria parte di rinunce, l'agricoltura potrebbe tirare un po' il fiato e lavorare di nuovo con quella vecchia pazienza contadina che già in passato la rendeva perfettamente sostenibile.
Con sommo sollievo anche del Fischione maculato della Val Frugazza.