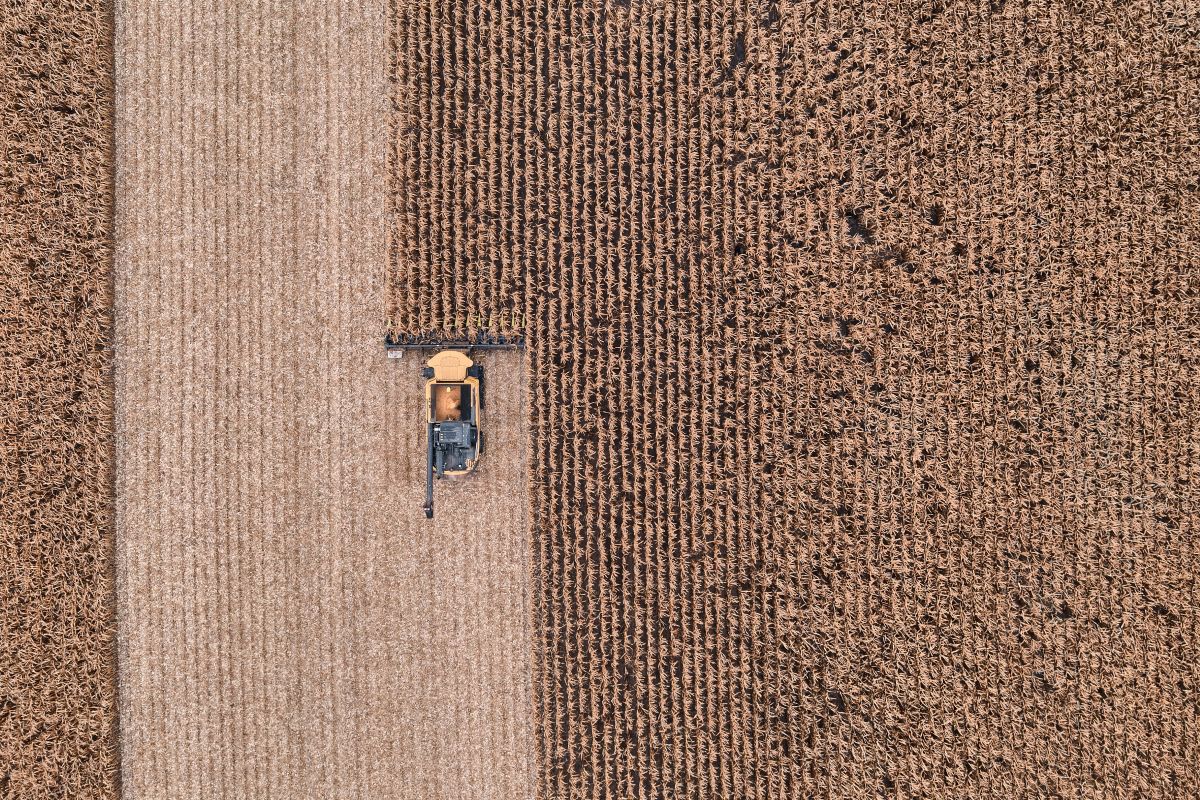Il richiamo alla sostenibilità delle pratiche agricole è quindi divenuto sempre più forte, indicando l'agricoltura intensiva come paradigma obsoleto e ormai superato, da rimpiazzarsi quindi con altre forme di coltivazione a supposto minor impatto ambientale.
Sebbene siano ampie le porzioni del Pianeta in cui alcune pratiche agricole scellerate hanno prodotto danni seri, l'analisi complessiva dei dati disponibili sollecita a riflessioni più pragmatiche e, forse, anche meno ideologiche. Anche perché la moderna agricoltura integrata, ben lungi dall'essere imparentabile con le monocolture più consolidate, si basa su una molteplicità di approcci differenti, fra cui anche le rotazioni e l'adozione di colture atte a restituire al terreno parte dei nutrienti sottratti, come per esempio avviene coltivando leguminose in alternanza e rotazione coi cereali. Ciò perché rotazioni e buone pratiche agronomiche sono patrimonio culturale di tutti e non solo di chi se ne arroga il possesso in esclusiva, come purtroppo capita di verificare sui media.
Per comprendere quali siano gli approcci più consigliabili da seguire in futuro, giova quindi consultare uno dei report più autorevoli in materia di clima, ovvero quelli prodotti periodicamente dalla Ipcc, acronimo di Intergovernamental panel for climate change, panel di esperti che lavora a livello globale per monitorare e misurare il fenomeno dei cambiamenti climatici.
Alcune risposte possono essere trovate per esempio nel Report "Climate change 2014 mitigation of climate change - Working group III contribution to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change", un tomo alquanto corposo di mille e 454 pagine che alla pagina 820 riporta in un solo grafico i dati che interessano il mondo agricolo.
In esso sono riportati i contributi totali in gas serra dei cosiddetti Afolu, acronimo di Agriculture, forestry and other land user, ai quali sono attribuite emissioni pari a circa il 24% di quelle complessive globali. Il range di dati copre un lasso di tempo che spazia dal 1970 al 2009.
Una prima evidenza che salta all'occhio riguarda l'andamento assoluto delle emissioni. Dopo un continuo aumento dal 1970 al 1999, nel decennio successivo appaiono in calo le emissioni medie annue di gas serra attribuite ad Afolu, le quali sarebbero tornate sotto le 10 gigatonnellate di CO2 equivalenti dopo aver toccato le 11 circa nel decennio 1990-1999.
Osservando il grafico, però, si evince anche come il 40% circa di tale valore derivi dal "forestry and land use change", ovvero dalla attività forestali e dai cambi di uso dei terreni. Tradotto, dalla conversione ad agricolo di prati e foreste, spesso tramite bruciatura, ulteriore causa di emissione diretta di CO2 nell'atmosfera. Per avere nuove terre, quindi, si emettono quasi 4 gigatonnellate sulle 10 attribuite spesso alla sola agricoltura. Questa è di fatto la voce più grande fra quelle elencate.
In sostanza, la prima variabile che incide sulle emissioni è a monte di qualsivoglia pratica agricola che verrà poi implementata su quei territori ex-naturali.
Ma agricoltura può voler dire anche zootecnia. In tal senso, gli allevamenti sarebbero causa di quasi il 20% delle emissioni degli Afolu tramite fermentazione enterica. Ovvero, 2 delle 10 gigatonnellate verrebbero dalle eruttazioni e dai peti degli animali allevati. Ma questi non concorrono alle emissioni solo in tal guisa. Anche la la gestione, la maturazione e l'uso del letame causano anch'esse circa un 13-14%, sommando le tre voci riportate nel grafico relative a "Manure management", "Manure applied to soil" e "Manure on pastures".
In italiano, la gestione delle deiezioni (letame e assimilati), letame applicato al suolo e letame sui pascoli. Perfino la torba ("Peat", nel grafico) pare gravare in modo significativo sul bilancio complessivo causa soprattutto bruciatura.
Infine, i fertilizzanti di sintesi rappresenterebbero circa lo 0,6-0,7% del computo totale.
In sostanza, per contrastare le emissioni di gas serra si dovrebbe bloccare innanzitutto la conversione ad agricolo di foreste e praterie. Ciò perché comporta un grande sforzo anche in termini di lavorazioni meccaniche basate sull'uso di combustibili fossili. In secondo luogo, andrebbe mitigato anche l'impatto dovuto agli allevamenti. Questi andrebbero infatti contenuti e ottimizzati al fine di minimizzare le emissioni, magari estraendo dalle deiezioni anche quella quota di energia che potrebbe ridurre il ricorso ai summenzionati combustibili fossili.
Ora, la meditazione stimolata da tali evidenze porta a interrogarsi sulla reale utilità di convertire l'attuale agricoltura ad alto rendimento in altre forme di produzione di cibo supposte meno impattanti, ma sicuramente anche meno performanti in termini di tonnellate di alimenti prodotti per ettaro.
Una conclusione cui pare siano giunte anche alcune ricerche recentemente pubblicate sul tema, come quella apparsa su Nature e firmata da Timothy D. Searchinger, Stefan Wirsenius, Tim Beringer e Patrice Dumas.
Il primo firmatario della ricerca opera presso la Princeton University e il World resources institute di Washington, negli Usa. Stefan Wirsenius è invece ricercatore presso il Department of Space, earth and environment della Chalmers University of Technology di Gothenburg, in Svezia. Tim Beringer, tedesco, lavora presso l'Integrative research institute on transformations of human environment systems (IRI THESys), presso la Humboldt-Universität di Berlino. Infine, Patrice Dumas, francese, il quale fa capo al Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired), a Montpelier, medesima città ove ha sede anche il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).
Anche secondo il comunicato stampa rilasciato dai quattro esperti, la cosa peggiore che possa essere fatta ai danni dell'atmosfera sarebbe quella di convertire ulteriori terre alla produzione di cibo. In sostanza, molto meglio fare rendere di più quelle che già attualmente coltiviamo che cercare soluzioni in forme di agricoltura meno produttive. Quelle cioè che spingerebbero ulteriormente al consumo sempre più massiccio di terra.
Se tutta l'agricoltura mondiale abbandonasse l'approccio intensivo, infatti, non si potrebbero che moltiplicare i dissodamenti di praterie e l'abbattimento di foreste al fine di procurare nuove terre atte a compensare le perdite produttive. Cioè quello che da solo rappresenta il 40% degli impatti attribuiti di fatto all'agricoltura.
In secondo luogo, abolendo i fertilizzanti di sintesi si dovrebbero moltiplicare proprio gli allevamenti atti a fornire anche deiezioni, come pure si dovrebbe aumentare la quota di terre da lasciare periodicamente a riposo per recuperare fertilità. E ciò metterebbe un ulteriore turbo alla deforestazione e all'aratura di nuove praterie, perché mentre i terreni riposano la gente non accetta certo di digiunare.
Infine, abbattendo l'uso della chimica, nella fattispecie gli agrofarmaci, saremmo obbligati a moltiplicare l'uso delle macchine, aggravando ulteriormente il bilancio complessivo causa impennata nei consumi di gasolio agricolo. E ogni chilo di gasolio, è bene ricordarlo, ne produce circa tre di anidride carbonica.
Al contrario di quanto da più parti si vagheggia, quindi, la soluzione non risiede affatto nel tanto auspicato ritorno al passato, farcito con varietà supposte antiche e con il bando di chimica e genetica. La vera soluzione risiede nella crescente integrazione di ogni possibile tecnologia atta ad aumentare sempre più le rese di ogni singolo ettaro già attualmente coltivato. Opportunamente miscelate fra loro, genetica, chimica, irrigazione, meccanizzazione ed elettronica offrono quindi le vere risposte a un mondo che cambia e che deve produrre sempre di più, impattando sempre di meno. Cioè la sostenibilità fondata sulla scienza anziché sull'ideologia o su altre forme di interesse economico.