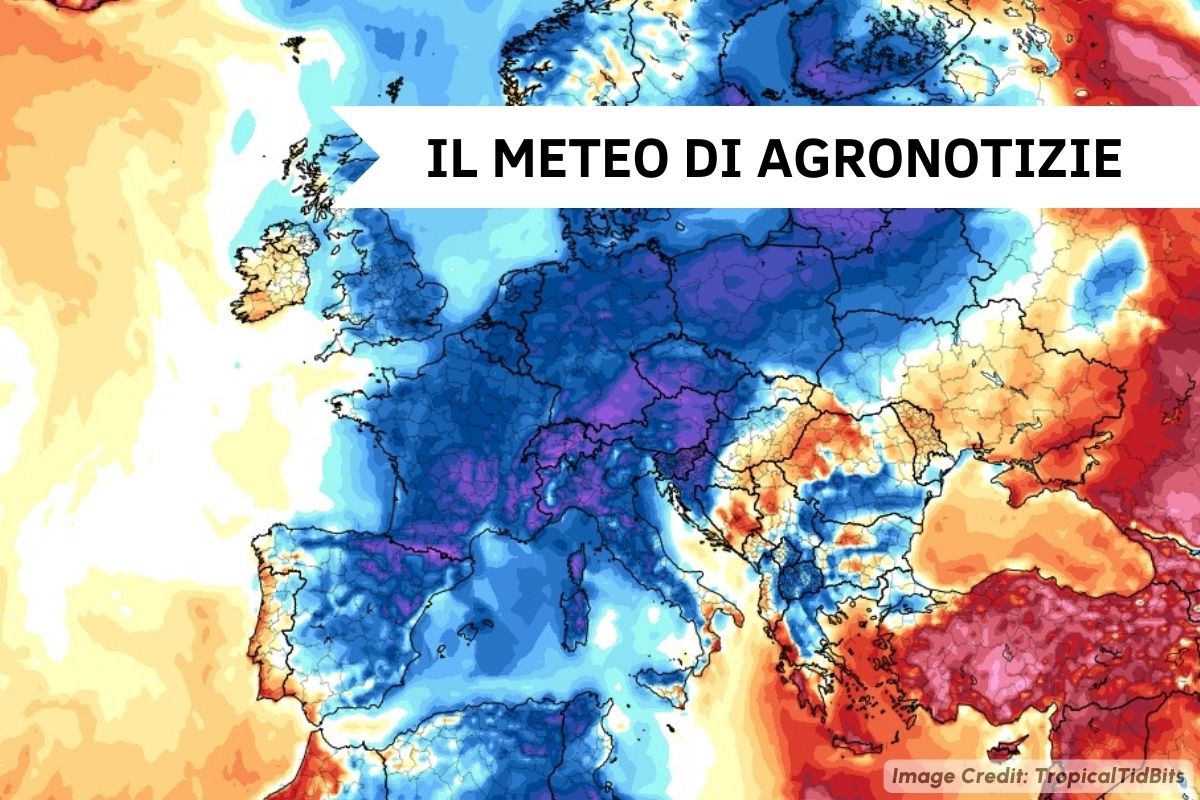E così, oggi, il Dna umano e di altre specie è molto simile a un vestito di Arlecchino. Genetico, ovviamente.
Per esempio, dei tre miliardi di “lettere” presenti nei nostri cromosomi circa il 44% è rappresentato dai trasposoni, ovvero piccole sequenze di Dna con l’abitudine di saltabeccare qua e là per il nostro genoma, il quale va perciò considerato come qualcosa in continua ebollizione anzichè un totem statico e immutabile come taluni erroneamente pensano. In più, quasi l’8% del nostro Dna, ci sarebbe arrivato dai virus. Ben 100 mila le sequenze virali che i ricercatori avrebbero infatti trovato accoccolate fra le nostre basi puriniche e pirimidiniche, tanto da far sollevare qualche dubbio perfino sugli stessi concetti di “nostro” e di “altrui”.
Anche nel Regno vegetale accadono trasferimenti analoghi. Il mais, per esempio, conta su un Dna il cui l’85%, cioè due miliardi di “lettere” su 2,3 totali, apparterrebbe a centinaia di famiglie diverse di trasposoni, i quali si sarebbero progressivamente accasati nel genoma di questa pianta. E quello che vediamo oggi è solo da considerare una fotografia degli scenari attuali. Chissà quanti tentativi sono stati fatti e poi abortiti nel corso di centinaia di milioni di anni di fitta interrelazione fra organismi differenti.
Citius, altius, fortius!
Quello sopra è il motto delle attuali Olimpiadi e in italiano significa “più veloce”, “più alto”, "più forte”. Un motto che a quanto pare è noto in natura ben prima che l’uomo s’inventasse i giochi a cinque anelli. L’apporto esterno di geni ha infatti dato una sorta di marcia in più agli organismi che li hanno ricevuti.In altre parole, il continuo inserimento di nuovi geni fin lì “alieni” ha permesso a molte specie di crescere ed evolversi più in fretta e in modo più aperto ed efficace, divenendo sempre più competitivi. Infatti, un conto è fare affidamento solo sulle mutazioni casuali del proprio Dna, un altro è trovarsi anche dei geni utili, belli e pronti, che ci arrivano dall’esterno e, se del caso, farli nostri a tutto beneficio delle nostre potenzialità evolutive.
Poteva forse il genere umano, inventore delle succitate Olimpiadi, esimersi dal far proprie queste opportunità previste dalla natura? Non che non poteva. E così negli ultimi decenni le biotecnologie hanno di fatto imitato proprio questi processi di scambio genetico, rendendoli però mirati a priori anzichè dover operare una scelta a posteriori: invece di aspettare che miliardi di geni siano trasferiti casualmente fra organismi diversi, per tenersi poi solo quelli utili, chi produce Ogm sa già a priori quali geni vuole sfruttare in una pianta o in un batterio(*). E quindi opera solo su quelli.
Uno dei sistemi più usati per produrre organismi geneticamente modificati si basa infatti sull’impiego di un comune batterio del suolo: l’Agrobacterium tumefaciens. Questo batterio sa infatti come “spennare la gallina senza farla strillare”. O meglio, sa come inserire i propri geni nei cromosomi altrui senza farsi dire di no. In pratica, un grande seduttore genetico in grado di trasferire parte del suo Dna (il T-Dna) alle piante, riuscendo a far credere loro che in ciò non vi sia nulla di strano, tanto che queste finiscono per considerarlo proprio.
In questo modo, da vero ammaliatore qual è, l’agrobatterio riesce a far fare alla pianta ciò che vuole lui. Ecco perché i ricercatori lo hanno utilizzato per conferire alle piante coltivate alcune specifiche caratteristiche. In pratica, la mano è del ricercatore, ma lo strumento chirurgico che egli utilizza lo ha inventato Madre natura.
A conferma, è giunta ora una scoperta fatta nel genoma della patata americana, quella dolce, tanto per intendersi. In questo tubero sono stati infatti rintracciati due differenti T-Dna: il primo è in comune fra le varietà selvatiche e quelle coltivate, il secondo è invece presente solo nelle varietà coltivate, risultando assente in quelle selvatiche.
Orrore e raccapriccio! Forse che già dieci mila anni fa vi erano “mad doctors” e multinazionali cattivone che pistolavano coi geni, anzichè lasciarli lì dov’erano, come taluni s’illudono che natura voglia? Niente affatto. La presenza di questo secondo tipo di T-Dna è figlia proprio d’interazioni naturali che hanno donato ad alcune varietà di patata americana quattro geni batterici nuovi di zecca. Questi avrebbero arricchito la pianta con nuove caratteristiche rendendola appetibile e quindi coltivabile. Senza quella transgenesi naturale, oggi, non avremmo il piacere di annoverare fra i nostri cibi questo tubero, il quale si aggiudica, almeno per il momento, il titolo di prima pianta gm pensata per il consumo umano diretto.
Con buona pace di coloro che guardano con irrazionale repulsione a una polenta fatta con mais Bt, o a una papaya modificata per resistere a un virus, o ancora a una mela ingegnerizzata per non imbrunire, o infine a una banana migliorata per non patire più di alcuni patogeni letali.
Coloro i quali, in sostanza, è davvero un gran bene non potessero esprimersi diecimila anni fa di fronte alla prima porzione di patata transgenica. Dolcissima…
(*) si dice "batterio" e non "battere", come per una svista avevo erroneamente riportato in un altro articolo. Svista che è stata immediatamente sanzionata con un pignolo pistolotto da parte di qualcuno che di tutto ciò che l'articolo diceva, pare che solo di quella svista abbia portato memoria... Si spera quindi che se anche venissero trovate imprecisioni nell'articolo di cui sopra, non si respinga maliziosamente l'intero pezzo solo perché contrasta su base scientifica certi convincimenti di matrice ideologica.