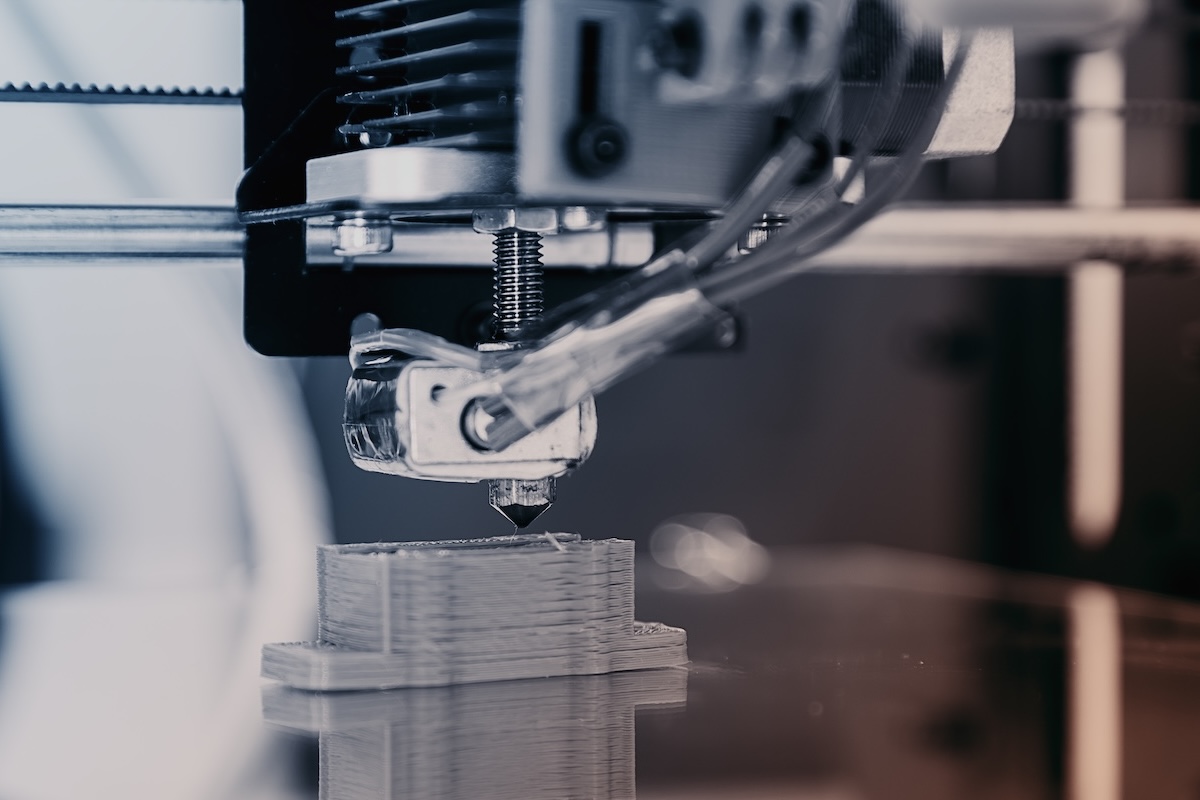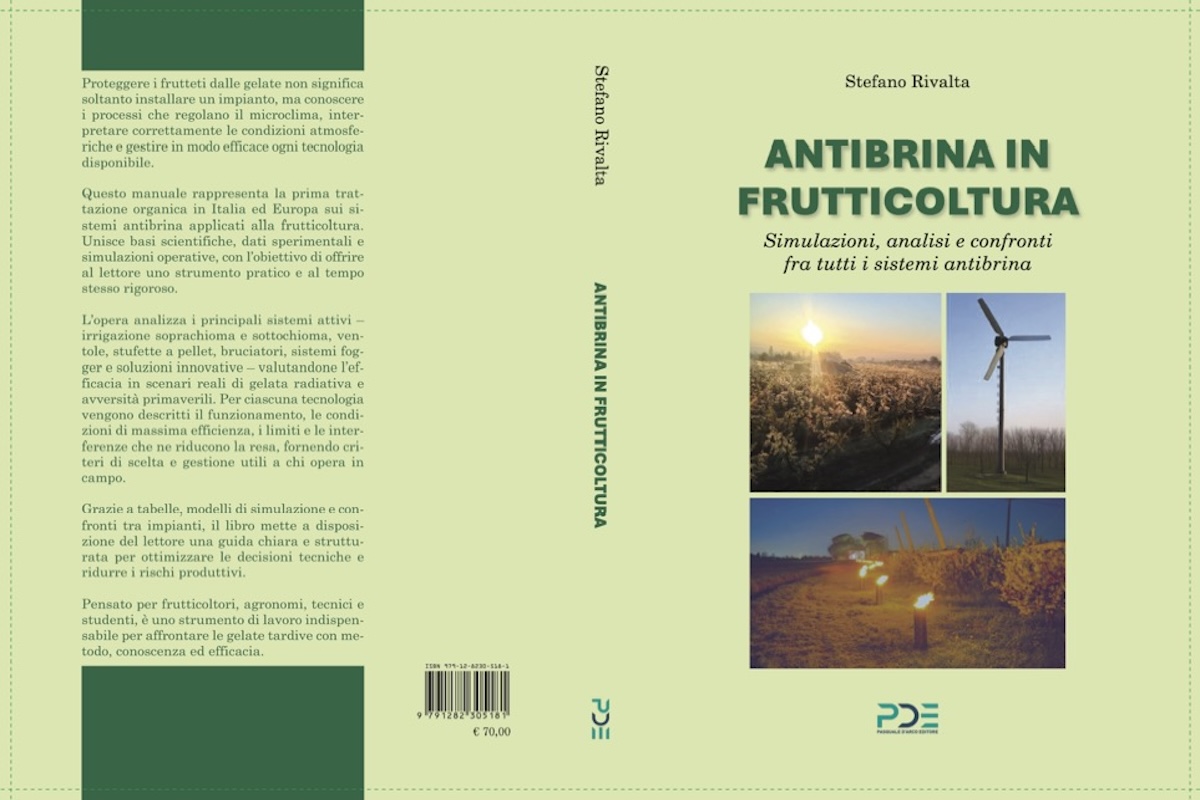Misteri dell'Urban Society moderna e dei bizzarri meccanismi alla base dell'attuale comunicazione di massa.
Quando poi si discuta specificatamente di Ogm o di agrofarmaci vengono talvolta espressi giudizi caustici perfino da soggetti che almeno sul piano della razionalità sono comunemente percepiti come autorevoli. Se ciò accade è perché la disinformazione operata su questi temi è stata così sistematica e virale da arrecare danni perfino a livelli insospettabili. Non basta cioè essere accademici di fama o autorevoli personaggi mediatici per essere al riparo dalle deformazioni sensazionalistiche che affliggono il mondo del biotech e della fitoiatria.
Fra i tanti disponibili, un esempio di quanto sia nebuloso il tema "pesticidi" si ricava da un articolo comparso sul numero dell'11 dicembre 2015 de Il Venerdì di Repubblica, supplemento settimanale del noto quotidiano.
A dare il "La" all'approfondimento è ancora lui: glifosate. Il Re di tutti i diserbanti e quindi anche di tutte le contumelie anti-fitoiatriche.
La querelle fra Iarc ed Efsa è infatti ancora molto calda, al limite della rissa, e ciò concorre a rendere vieppiù delicata la trattazione dei temi tossicologici e ambientali legati a questa molecola.
Già nel titolo, "L'erbicida sotto accusa nel mondo. E in Europa no", vi è però un'imprecisione. Glifosate è infatti sotto accusa proprio ovunque, anche in Europa. Bisogna però vedere da parte di chi.
E per ragionare su questo punto ci si deve rifare a un altro passaggio dell'articolo, ovvero quello in cui si afferma che "Queste accuse non convincono però tutta la comunità scientifica". Messa così, però, chi legge potrebbe essere portato a credere che la maggior parte della suddetta comunità sia contraria all'erbicida, mentre solo una minoranza di "negazionisti" lo approvi.
Al contrario, glifosate ha convinto proprio tutta quella parte della comunità scientifica che conta, ovvero quella coinvolta nei processi registrativi che hanno portato l'erbicida a essere commercializzato in tutto il mondo. In Europa, per esempio, glifosate ha superato anche il severo processo della Revisione Europea, operata proprio da referenti scientifici le cui competenze sono altamente specifiche per compiere tali valutazioni, come il Bundesinstitut für Risikobewertung, cioè l'istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi. E nella Scienza, dolente per chi la pensi diversamente, uno non vale uno e per tale ragione sarebbe bene parlassero solo coloro che sono più qualificati a farlo. Il resto è gazzarra da Facebook.
L'Efsa rincara le critiche
Alle contestazioni già palesate nei confronti dello Iarc per bocca di José Tarazona, direttore dell'Unità Pesticidi dell'Efsa, l'ente europeo aggiunge ora anche l'aspetto dei prodotti utilizzati nei test: l'Efsa avrebbe infatti soppesato ricerche effettuate sulla sola sostanza attiva, mentre lo Iarc avrebbe considerato pure quelle realizzate utilizzando formulati commerciali, ottenendo risultati ovviamente diversi.Secondo la tossicologa Kate Guyton il metodo considerato dallo Iarc sarebbe però il più valido fra i due. Non solo perché gli usi in campagna prevedono l'impiego dei formulati e non della sostanza attiva in sé, ma anche perché lo Iarc avrebbe valutato solo studi pubblici, pubblicati su riviste scientifiche e quindi, ça va sans dire, "liberi da conflitti di interesse".
E già qui i dibattiti potrebbero essere almeno due. Il primo sui formulati, il secondo sui conflitti d'interessi. Circa il primo si deve convenire che in effetti è vero: in campagna si utilizza un formulato commerciale e non la sola sostanza attiva. Ma lo si applica in campagna, mica nelle padelle da cucina, per giunta diluito in svariati ettolitri di acqua. E questo non è affatto un dettaglio da poco.
Per esempio, i formulati liquidi di glifosate al 36% vengono per lo più applicati dai due ai sei litri per ettaro, diluiti in 300-400 litri di acqua. In pratica, la soluzione irrorata nei campi mostra nella maggior parte dei casi delle concentrazioni comprese dallo 0,5 al 2% di formulato e dallo 0,17 allo 0,7% di sostanza attiva. Il tutto, spalmato su 10 mila metri quadri di terreno.
Utilizzare i formulati commerciali, anziché la sola sostanza attiva, può quindi essere corretto quando si debba valutare un farmaco da ingerire o da iniettare, ma sconfina nel ridicolo parlando di un agrofarmaco spruzzato in campo, per giunta diluito in quintali di acqua.
Visto quanto appena detto, se trattiamo con un formulato commerciale tal quale delle cellule placentari coltivate in vitro, stiamo quindi realizzando uno studio che rispecchia situazioni verificabili nella realtà, oppure stiamo procedendo in uno studio che con la realtà nulla ha a che vedere? Alla placenta di una donna in gravidanza, in sostanza, cosa potrebbe mai arrivare: glifosate, oppure il formulato? Forse (ma molto forse...) il primo, non certo il secondo. Ricerche di questo genere, e ne esistono purtroppo in gran copia, partono cioè da presupposti totalmente irrealistici. E se sono irrealistici i presupposti, figuriamoci i risultati. Senza poi considerare che in vitro non si può nemmeno contare sui processi di detossificazione che l'organismo schiera normalmente contro le molecole xenobiotiche, come appunto avviene con gli agrofarmaci.

I formulati vengono fortemente diluiti in acqua e quindi irrorati nei campi. Utilizzarli tal quali nei test di laboratorio non ha alcun senso nella valutazione del rischio
(Fonte foto: © Federico Rostagno - Fotolia)
Un po' meglio appaiono quindi gli studi su organismi complessi, come ratti e topi. Ma anche in questo caso appare gara dura estrapolare giudizi corretti sui rischi per gli Umani da test in cui alle cavie siano stati somministrati formulati commerciali, magari a dosi stratosferiche.
Studi del genere, quindi, hanno senso oppure no? Ad avviso di chi scrive, hanno senso solo quando considerati per quello che sono: esercizi accademici atti a valutare un rapporto causa-effetto avulso da qualsivoglia implicazione di tipo ecotossicologico, mancando totalmente dell'esposizione reale alla sostanza. Non sono perciò studi idonei al processo di valutazione del rischio per l'uomo, in quanto veri e propri "crash test" in cui si provoca deliberatamente un disastro per valutare la portata di un avvelenamento estremo.
Da qui alla stima del rischio ci corre come dalla Terra alla Luna.
Purtroppo, è invece ormai invalso l'uso di sbandierare i suddetti "crash test" come prova della pericolosità per l'uomo di qualsiasi cosa. E l'opinione pubblica abbocca a questi ami come una trota di torrente alla mosca del pescatore. Perché il "pescatore" c'è, eccome. Ma qui si deve passare al secondo dei due punti: siamo sicuri che i conflitti d'interessi siano interpretati correttamente? Al momento vengono considerati solo quelli puramente economici. Se un dossier è redatto da un'azienda, questo viene infatti rifiutato dallo Iarc in quanto considerato non esente da influenze di interessi privati. Se invece un lavoro scientifico viene effettuato da gruppi di ricerca indipendenti questo viene accettato serenamente, reputandolo scevro da influenze extra-scientifiche. Peccato che in tal modo s'ignorino i possibili orientamenti ideologici e culturali di chi le ricerche le svolge.
Infatti, anche senza scomodare studi risibili come quello sugli Ogm dell'ormai noto Gilles Séralini, indipendente dalle multinazionali del biotech, ma a suo tempo legato ai finanziamenti di Auchan e Carrefour, cosa garantisce che un soggetto pubblico sia più attendibile di uno privato? Nulla. Perché l'ideologia può essere perfino più potente di una "stecca" monetaria e per giunta passa sotto traccia se l'unico criterio utilizzato è quello meramente economico.
Seguendo tale discrimine manicheo e pregiudizievole, si rischia cioè d'infiltrare gli archivi bibliografici con studi che avevano come unico e preciso intento quello di "dimostrare che", anziché il molto più scientifico "verificare se". E di ricercatori col camice bianco fuori ma la maglietta di Greenpeace alla pelle - per lo meno idealmente - ne ho conosciuti parecchi in vita mia.
Cosa si deve infatti pensare di un gruppo di ricerca che tratta le cavie di laboratorio a dieci volte la dose di etichetta, concludendo e sbandierando ai quattro venti che i "pesticidi" sono letali? Oppure che espone girini di rana a dosi di milligrammi per litro quando nell'ambiente si trovano concentrazioni di microgrammi, cioè mille volte più basse?
E infine, ultima domanda: i risultati di tali ricerche possono servire per avere un'idea oggettiva del rischio per l'uomo e per l'ambiente, o sono, appunto, dei "crash test" che con l'ecotossicologia hanno quasi nulla da spartire?
Come forse direbbe Quelo di Corrado Guzzanti: "La seconda che hai detto..."
Non a caso, infatti, nel pezzo comparso sul Venerdì, Kate Guyton ammette che la cancerogenicità sull’uomo è stata dedotta da soli tre studi, effettuati peraltro su piccoli gruppi di agricoltori in Canada, Svezia e Usa, mentre quella sugli animali si sarebbe verificata in topi esposti ad alte dosi di glifosate. Alte dosi. Ancora. Perché in effetti la differenza nei giudizi fra Iarc ed Efsa pare sia tutta qui: il primo valuta la pericolosità intrinseca di una molecola o di un formulato commerciale, somministrati per giunta a dosaggi molto più elevati di quanto avvenga in questa dimensione spazio-temporale. L’Efsa ragiona invece sulla base del rischio concreto e ragionevole. Concetti, questi, legati strettamente a quello di esposizione reale. Esposizione che l'Efsa ritiene infatti del tutto trascurabile, dal momento che nelle acque l'erbicida sotto accusa sarebbe trovato a concentrazioni inferiori all'uno per cento della dose giornaliera ammissibile. Cioè quella ritenuta sicura per l'uomo essendo calcolata dividendo per 100 la No Effect Level di laboratorio. Una dose, quest'ultima, che già di per sé significa "innocuità".
Un parere, questo, condiviso anche da Claudio Della Volpe, docente di chimica-fisica presso l'Università di Trento, il quale dopo aver ascoltato Iarc ed Efsa considera "relativamente limitati" i rischi per la popolazione.
Traducendo quanto sopra in un esempio surreale, l'Efsa sa benissimo che se fai scolare a una cavia una bottiglia di grappa da 50 gradi la mandi in coma etilico e la uccidi, ma sa altrettanto bene che ciò non significa affatto che un uomo corra simili rischi per l'alcol che assume tramite una lattina di birra da quattro gradi e mezzo, bevuta magari in accompagnamento di una pizza con gli amici.
Si chiama buon senso, si chiama intelligenza. Cioè quei beni preziosi che quando si parla di agrofarmaci pare cadano nell'oblio, giustiziati da opinioni che s'impongono sui fatti grazie al preoccupante vuoto culturale tecnico circa i temi agricoli in generale e fitoiatrici in particolare.
Ecologia o ecologismo?
Nell'articolo compare poi l'intervento di Carlo Modonesi, professore di ecologia umana all’Università di Parma, secondo il quale quando si parla di cancerogenicità sarebbe meglio ascoltare lo Iarc. Opinione la quale, se applicata in modo rigoroso, dovrebbe portare il professore parmense a cancellare dalla propria dieta salumi e bistecche, sempre che non lo abbia già fatto, visto che proprio lo Iarc ha inserito nel gruppo 2a, il medesimo del glifosate, anche le carni rosse e addirittura nel gruppo 1 gli insaccati, posti al fianco di amianto, benzene e radiazioni ionizzanti. E se lo Iarc viene considerato giudice insindacabile per il glifosate, non si capisce bene perché non lo debba essere anche per i panini al salame.Non poteva mancare ovviamente una tiratina sul biologico. Intervistato infatti sulle alternative all'uso dei diserbanti, il professore di Parma ricorda come intorno a Milano il 10% delle aziende agricole si sia convertito al biologico, sostituendo gli erbicidi con sarchiature, pacciamatura e rotazione delle colture.
Da un professore di ecologia, però, ci si aspetterebbe un'analisi dei fatti un po' più approfondita, che non si fermasse cioè ai soli agrofarmaci. Fatto salvo innanzitutto che nel biologico la rinuncia ai "pesticidi" è spesso dichiarata, ma non veritiera(1)(2)(3)(4), la sarchiatura non è poi applicabile a tutte le colture.
I due milioni di ettari di frumento che vengono coltivati in Italia, per esempio, non possono essere gestiti con queste pratiche. E peraltro, nemmeno le colture sarchiabili come mais e soia danno sempre risultati eccellenti. Anzi.

Risultati in campo di tre passaggi meccanici per il controllo delle malerbe su mais.
Prove eseguite a Lodi in collaborazione fra Università di Torino, di Milano e Agricola 2000, centro di saggio
Inoltre, se non si usano diserbanti, in primis glifosate in presemina, non è applicabile la pratica della semina su sodo, la quale consente di ridurre i consumi di gasolio a beneficio non solo del portafoglio dell'agricoltore, ma anche delle emissioni di anidride carbonica per chilo di alimenti prodotti. Quando poi venga applicata in aree collinari, la semina su sodo (e suoi diserbi) permette anche di evitare al terreno proprio quelle lavorazioni meccaniche che lasciano esposti i crinali alle azioni di piogge e vento. E temi come le emissioni di CO2 e il dissesto idrogeologico dovrebbero essere poste al centro quando si parli di ecologia e si voglia dissertare dei rapporti fra agricoltura, agrofarmaci e ambiente.
Senza peraltro dimenticare che quando l’agricoltura poteva contare solo sulle lavorazioni meccaniche e sulle rotazioni le perdite nei raccolti causate dalle malerbe variavano dal 20 al 50%, a seconda degli anni e delle colture. Un aspetto, quello delle rese, che troppe volte viene trascurato da chi oggi non pare capire bene lo stretto legame fra gli agrofarmaci impiegati in campo e i suoi tre pasti al giorno.
A dare risposte a tali questioni ci prova quindi Lorenzo Faregna, direttore di Agrofarma, ricordando i 40 anni di studi tossicologici e ambientali dai quali non emergerebbero a carico di glifosate i vari problemi paventati sopra. Come pure prova a ricordare, il buon Faregna, il ruolo fondamentale e irrinunciabile degli agrofarmaci e delle buone pratiche agricole che stanno alla base del loro utilizzo (ebbene si: esistono e sono imposte da direttive Ue recepite in Italia attraverso il Pan).
In sostanza, mentre la loro importanza sociale è di gran lunga superiore a quanto viene percepito, i loro impatti ambientali e sanitari sono di gran lunga inferiori a quanto propagandato.
Un rapporto costi/benefici che si mostra cioè assolutamente favorevole dal punto di vista alimentare, economico, sociale, ambientale e sanitario.
Peccato quindi dare sempre addosso agli agrofarmaci mostrando solo la faccia negativa della medaglia e omettendo (furbescamente? ottusamente?) quella positiva.
Sarà ascoltato Faregna? Impresa ardua, visto e considerato il clima forcaiolo nel quale la fitoiatria si deve muovere ormai da alcuni decenni. E poi tanto lui "c'ha i conflitti d'interessi", si sa, mentre le montagne di denaro generate dal bio, falso o vero che sia, vanno tutte in beneficienza...
Quella contro glifosate appare quindi e per lo più una guerra ad molecolam, fatta con armi di disinformazione di massa abilmente giostrate da lobby che traggono il proprio sostentamento anche dalle crociate contro gli agrofarmaci.
Non risponde infatti al vero affermare che non esistono studi specifici su queste molecole, né tanto meno è vero che non si sappia quanto glifosate venga assunto dai cittadini e che effetti esso possa avere sulla nostra salute. Perché una cosa è infatti certa e lapidaria: l’assunzione di glifosate tramite cibi e acque è sideralmente lontana dalla dose giornaliera ammissibile stabilita dalla tossicologia e dalle normative vigenti. Non a caso, negli Usa il suo limite nelle acque è 7.000 volte più elevato rispetto a quello italiano. E non è che siano dei matti loro, perché il valore di 700 µg/L, usato in America come soglia di sicurezza, è ricavato da calcoli di origine tossicologica.
Quindi tutt'altro che campati per aria, contrariamente a certe mozioni abolizioniste inoltrate da chi pare capisca di agrofarmaci un po' meno di quanto io capisca d'uncinetto.
Intanto, però, e in barba a tutto quanto sopra, vi sono già dei Paesi che sarebbero stati spinti a restringere o a bandire l’uso di glifosate, come per esempio El Salvador e Sri Lanka. E ben vengano. Anzi, magari fossero di più, includendo però anche qualche realtà agricola di rilevanza mondiale. L'Italia, per esempio. Così, almeno, dopo qualche anno di purismi ambientalisti, tanto spropositati quanto immotivati, si potrebbe capire con estrema facilità ciò che al momento pare sfugga del tutto. Una presa di coscienza salutare che farebbe un gran bene a tanti livelli della società. Inclusi gli uffici dello Iarc, le redazioni dei giornali e le sedi universitarie.
Non resta quindi che concludere l'articolo con una sola speranza: un lungo digiuno ci salverà?