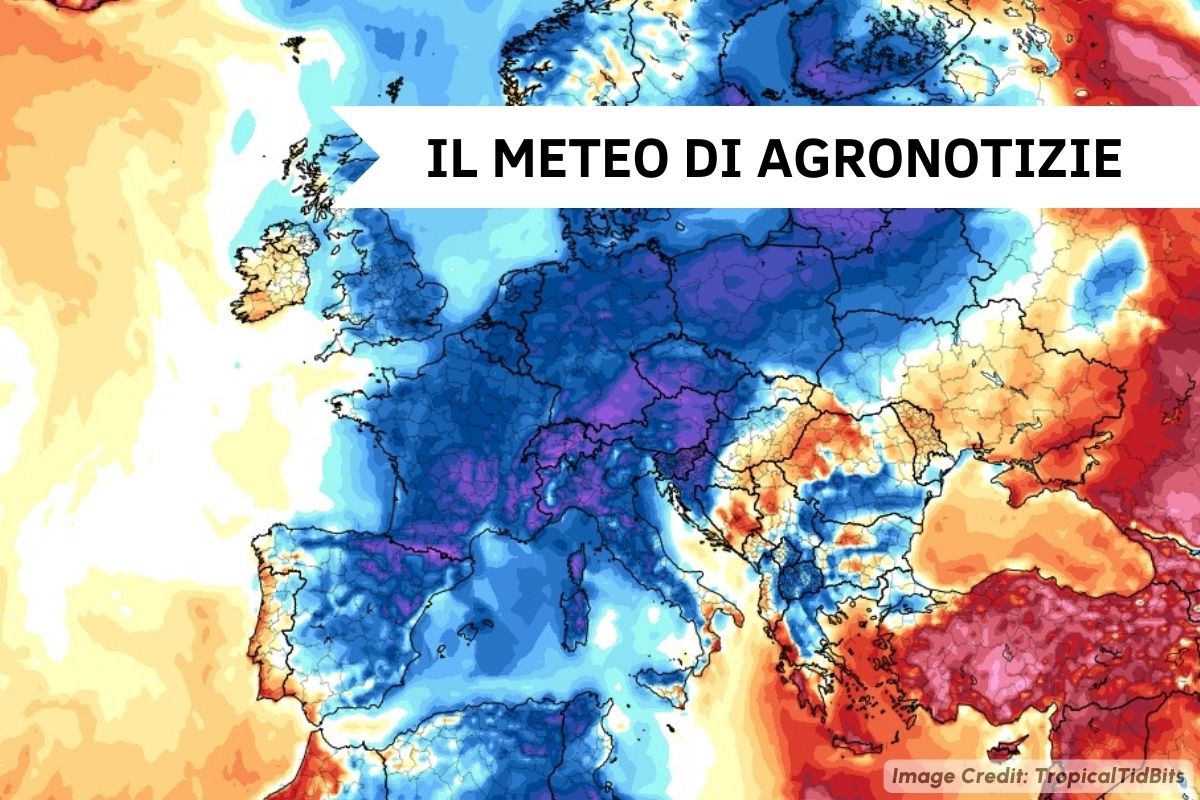Nel primo dei due continenti il Fatto Alimentare ha pubblicato i risultati di una ricerca di Epilobee dalla quale parrebbe che la perdita di colonie sia meno grave di quanto vaticinato, sebbene sussistano ancora patogeni e parassiti con i quali api e apicoltori devono fare comunque i conti. Nel secondo è il Washington Post a ribadire più o meno gli stessi concetti, mettendo anche un po' alla berlina i modi con cui la faccenda api sarebbe stata da sempre trattata, abusando per esempio di termini come "Beemageddon" e "Beepocalypse", i quali paiono per lo più inclini alla tragedia e al sensazionalismo.
Negli Usa, secondo il quotidiano americano, le colonie sarebbero infatti continuamente cresciute negli ultimi vent'anni, mostrando un temporaneo inciampo giusto intorno al 2006, anno in cui le morie sarebbero state denunciate la prima volta.
Ovvi gli stracci delle vesti di chi invece pare sia contento solo quando gli si dice che moriremo tutti entro venerdì.
È vero, un aumento nel numero delle colonie non implica un aumento di api in sé. Si potrebbe infatti verificare la situazione per cui sono aumentate le prime, ma diminuite le seconde. Vi sono però diversi modi di analizzare le questioni: il primo allarmistico e demagogico, il secondo razionale ed "evidence based", cioè basato sui numeri. Il secondo è sempre da prediligere quando si voglia fare chiarezza, il primo invece quando si voglia alzare del torbido entro il quale razzolare al meglio.
Numeri e numeri
Partiamo da un punto di vista meramente numerico e parliamo di colonie. Negli Usa queste avrebbero toccato un apice negli Anni 50, con oltre cinque milioni e mezzo di unità, salvo poi declinare lentamente nei decenni successivi. Quando giunse il 2006, anno delle cosiddette Ccd, acronimo di colony collapse disease, erano cioè alcuni anni che il censimento stallava poco sopra i due milioni e mezzo di colonie, sconfinandovi al di sotto appunto nel 2006-2007. Da lì in poi la ripresa, come riassunto dall'articolo del Washington Post.Vi sono poi casi come quelli del Nord Dakota, lo Stato che in America produce da solo più di un quinto del miele nazionale, ove il problema delle api sarebbe stato affrontato e risolto lavorando in stretto contatto con gli apicoltori. Questi non solo avrebbero ripreso a fare produzioni record, ma sarebbero pure aumentati del 5%. Segno che quando un business tira, altri giocatori vogliono entrare in partita (leggi l'articolo).
Sorge quindi spontaneo il dubbio sulle reali intenzioni di chi ha coniato termini nefasti come quelli di cui sopra, ideali più che altro per attrarre l'attenzione pubblica, non certo per inquadrare il problema in modo corretto ed equilibrato.
Nel frattempo, secondo l'Usda, la produzione nazionale di miele sarebbe infatti rimasta relativamente stabile intorno ai 150 milioni di libbre, pari cioè a 330 mila tonnellate, con il 2008 e il 2010 che si sono rivelati sopra la media del settennato 2006-2012.
Non si capisce quindi a cosa sia dovuta la contemporanea esplosione del prezzo del miele, perché di certo non vi è correlazione con i cali interni di produzione, peraltro compensati da crescenti importazioni atte a seguire la domanda locale. L'aumento dell'import non pare infatti sia servito a compensare le fallanze nazionali, bensì per star dietro a una domanda di miele in crescita. Una crescita che non può però giustificate un aumento dei prezzi al chilo di oltre due volte e mezza in soli otto anni. Già, perché i prezzi per libbra, unità di misura equivalente a circa 453 grammi, sono saliti in America dagli 0,8 dollari del 2005 ai 2,1 dollari del 2013. In dollari al chilo si è quindi saliti da 1,77 dollari/kg a 4,63 dollari/kg. Un incremento, appunto, di circa il 260% nel giro di otto anni. Una vera e propria deflagrazione che induce forti sospetti di speculazioni programmate a tavolino.
In sintesi, dagli anni del massimo clamore sull'estinzione globale delle api, le colonie statunitensi sarebbero leggermente aumentate, le produzioni non sarebbero affatto crollate, ma i prezzi in dollari sarebbero lievitati. Forse i consumatori americani di miele dovrebbero quindi interrogarsi sui perché si levino periodicamente le grida di un comparto il quale, ben stampellato da associazioni ambientaliste e demagoghi vari, pare tragga notevoli vantaggi da tale allarmismo, sia dal punto di vista commerciale, sia mediatico.
E magari sarebbe bene che i suddetti consumatori, anche europei e italiani, iniziassero pure loro a restare con nervi saldi davanti agli scenari apocalittici cui siamo purtroppo abituati in materia di api. Perché gli interessi e il profitto, non tutti lo comprendono, non sono prerogativa esclusiva di BigPharma e dei tanto odiati colossi multinazionali.